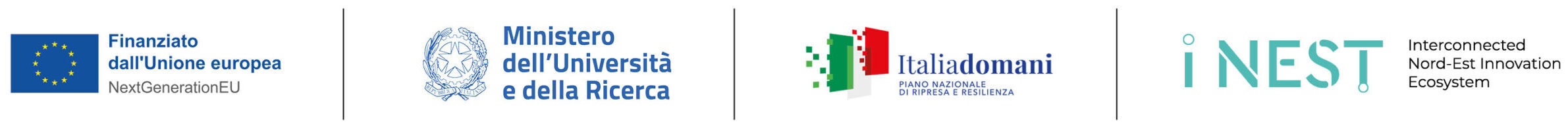Se la seta cura il cuore
Un progetto di ricerca dell’Università di Trento – Spoke 2
Un progetto che studia come riparare un tessuto cardiaco post-infarto grazie all’impiego di biomateriali naturali. Il progetto è finanziato dall’Ecosistema Inest a valere sui fondi NextGeneration Eu (Pnrr).
Creare in laboratorio un modello ingegnerizzato tridimensionale di cuore per studiarne i meccanismi e correggerli in caso di malfunzionamento. Sembra fantascienza e invece siamo nel campo della bioingegneria e ricerca biomedica, ossia uno spazio multidisciplinare che permette di studiare meglio aspetti fisiologici e patologici degli organismi viventi per arrivare a una conoscenza più profonda delle malattie umane e progettare terapie innovative.
Nel Centro per le tecnologie biomediche – Biotech dell’Università di Trento si sta lavorando per
costruire un modello in vitro di tessuto cardiaco, osservare come cambia se colpito da una patologia
– un infarto per esempio – e immaginare possibili interventi riparatori e curativi, sempre più
personalizzati. Anche grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal Programma Inest –
Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (su fondi NextGeneration Eu) di cui l’Università di
Trento è leader dello Spoke 2 “Health, Food and Lifestyle” che avrà come missione quella di
sviluppare l’innovazione tecnologica e sociale per promuovere la salute e il benessere umano e
sostenere la transizione digitale e verde dei sistemi sanitari del Triveneto.
La tematica di progetto ha riscosso notevole interesse anche da parte delle aziende. Vista la sua
valenza scientifica, è stato inserito anche tra i progetti strategici dell’Ateneo di Trento.
Il progetto
Le responsabili di questa ricerca all’avanguardia sono Antonella Motta e Annalisa Tirella. Entrambe docenti al Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Trento sono specializzate nello studio dei biomateriali naturali come proteine, polisaccaridi e bioceramiche, utili per la rigenerazione dei tessuti.
In particolare, la professoressa Motta dirige un laboratorio dove vengono ingegnerizzati in vitro micro-tessuti a partire da materiali come la seta, su cui testare l’efficacia di farmaci anti-tumore o per altre patologie. Una soluzione altamente innovativa, di qualità, ma anche sostenibile dal punto di vista ambientale. Questi temi di ricerca e innovazione sono orientati a sostenere il percorso di sviluppo di soluzioni innovative che sono i principi su cui si basa l’ecosistema Inest.
«Si tratta di tecnologie naturali capaci di far crescere cellule differenziate tipiche del tessuto cardiaco, che quindi ne permettano la contrazione e di mantenere tutte le caratteristiche che sono tipiche del cuore», spiega la professoressa Tirella. «Questi sistemi – prosegue – ci servono non tanto per mimare il funzionamento del cuore, quanto per vedere come cambia questa funzionalità quando insorge una patologia che varia la composizione del tessuto, e di conseguenza la frequenza cardiaca o la forza di contrazione. Per fare questo, stiamo cercando di sviluppare sia un modello di cuore battente che riproduca le caratteristiche di un adulto sano, sia un modello che invece presenta caratteristiche fibrotiche, più simile a tessuti cardiaci post-infarto».
Una ricerca di base preclinica, che parte da competenze bioingegneristiche. I tessuti viventi sono formati da una parte cellulare e da una parte extracellulare: questi modelli in vitro vengono progettati e ricreati con materiali che vanno a mimare la parte extracellulare dei tessuti, all’interno dei quali vengono poi integrate le cellule viventi.
«Queste cellule si chiamano, in inglese, “induced pluripotent stem cells”. Sono cellule staminali pluripotenti che vengono differenziate e che ci permettono di capire cosa succede in un organismo umano», spiega ancora Tirella.
In questo momento è stato realizzato il primo prototipo di tessuto cardiaco sano e si è nella fase della caratterizzazione e validazione dei materiali. Si prevede che entro i prossimi sei mesi saranno realizzati i due prototipi funzionanti che potranno essere poi testati con trattamenti medici mirati.
«Tutti i materiali che vengono utilizzati per mimare la parte extracellulare del tessuto cardiaco – precisa Antonella Motta – sono di origine naturale e non producono scarti tossici per l’ambiente. Sono derivati da alghe e da bozzoli della seta, e si chiamano rispettivamente alginati e fibroina della seta. L’idea è creare una filiera di sostenibilità che certifichi il grado di purezza di questi componenti». In prospettiva, l’obiettivo di questo lavoro è di arrivare ad una medicina di precisione. Questi sistemi ingegnerizzati permetterebbero infatti anche di rigenerare i tessuti cardiaci post-infarto.
Annalisa Tirella fa un esempio calzante per illustrare come questi modelli permettano di aumentare la conoscenza attuale del comportamento cellulare: «Immaginiamo una persona che viene spostata dal suo ambiente naturale e messa a riposare su un divano oppure su una lastra di marmo. Al momento i sistemi di screening farmacologici studiano le cellule del paziente disposte su una plastica dura e piatta. Quello che noi facciamo è fornire a queste cellule un ambiente più confortevole e più simile possibile a quello da cui sono state prelevate. Questo ci permette di vedere come rispondono agli stimoli meccanici, fisici, chimici e biologici. Se le cellule vengono condizionate in un ambiente tridimensionale che assomiglia al tessuto di origine potrebbero dare una risposta diversa da quella fornita nei metodi tradizionali che vengono utilizzati per lo screening farmacologico. E quindi è facile intuire che in questo modo si potranno avere trattamenti e dosi di medicinali più personalizzate».
Il progetto ha ottenuto un finanziamento per una borsa di studio postdoc della durata di due anni e supportata da bandi “young researcher” proposti all’interno dell’ecosistema Inest. «Ma secondo me il contributo maggiore – sottolinea la professoressa Motta – è stato quello di darci la possibilità di entrare in un ecosistema che mette in dialogo industria e accademia e di interfacciarci con realtà nel nord est interessate a innovare, sviluppare e implementare nuove tecnologie».
Una gallery di immagini del progetto – credits: @UniTrento – BIOtech